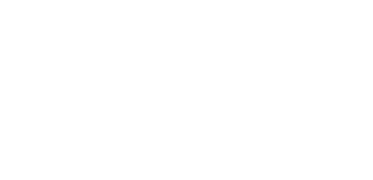L’acqua è una risorsa indispensabile per lo sviluppo, la coesione e la transizione energetica. Lo stato dell’arte, i problemi infrastrutturali del Mezzogiorno e il gap tra risorse stanziate e fabbisogno di investimenti.
La Giornata mondiale dell’acqua (22 Marzo) a cui prestare massima attenzione: l’acqua è indispensabile per garantire la salute pubblica e la coesione sociale.
Il cambiamento climatico e la maggiore frequenza e intensità degli eventi metereologici estremi contribuiscono a rendere i flussi d’acqua sempre più irregolari, con il rischio concreto di mettere a repentaglio la sicurezza idrica nazionale a fronte di fabbisogni crescenti, specialmente nel Mezzogiorno. L’alternanza di fenomeni opposti – il moltiplicarsi degli eventi siccitosi, l’innevamento ai minimi storici all’inizio del 2023, gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna e Toscana – impone la necessità di una riorganizzazione complessiva nella gestione della risorsa idrica per migliorare la capacità di adattamento del sistema. Questa azione obbligata non può che passare da una prospettiva di filiera in grado di abbracciare il ciclo idrico nella sua interezza: dalle principali tipologie di utilizzo della risorsa idrica alle interdipendenze settoriali del comparto.
Secondo i recenti dati sulla rete idrica italiana pubblicati da ISTAT, nel 2022 le perdite nelle reti dell’acqua potabile hanno raggiunto il 42,4% dell’acqua immessa in rete, un dato in lieve peggioramento rispetto agli anni precedenti (42,2% nel 2020 e 42,0% nel 2018) e sensibilmente superiore alla media europea (intorno al 25%). In termini assoluti, la quantità di acqua dispersa nella fase di distribuzione continua a rappresentare un volume tale (3,4 miliardi di m3 annui) da soddisfare le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno.
La situazione è particolarmente critica nel Sud (50,5%) e nelle Isole (51,9%), dove 7 regioni su 8 fanno registrare un dato peggiore della media nazionale per quota perdite, con i valori più elevati in Basilicata (65,5%), Abruzzo (62,5%), Molise (53,9%), Sardegna (52,8%) e Sicilia (51,6%). Tale divario territoriale è determinato da profondi squilibri infrastrutturali che a loro volta si riflettono in una diversa qualità del servizio offerto (il c.d. water service divide) aggiungendosi alla lunga lista dei divari di cittadinanza tra Nord e Sud.

La debolezza infrastrutturale del Mezzogiorno risulta particolarmente preoccupante se combinata alla dinamica della disponibilità idrica nazionale che ISPRA ha certificato pari a 112,4 miliardi di m3 nel 2023. Un volume ridottosi del 18% rispetto alla media annua 1951–2023 a causa del deficit di precipitazioni e dell’incremento dei volumi idrici di evaporazione diretta dagli specchi d’acqua e dal terreno. I fenomeni di siccità estrema, sempre più frequenti e diffusi a livello territoriale, hanno caratterizzato i territori del Nord e del Centro nei primi mesi del 2023, mentre tra ottobre e dicembre – generalmente i mesi più piovosi dell’anno – si è registrato un consistente deficit di precipitazioni in Sicilia e nella Calabria ionica, con effetti che si sono protratti nei primi mesi del 2024. Gli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici e le Autorità di Bacino Distrettuale hanno messo in luce che, già dal mese di febbraio, la Sicilia e la Sardegna sono interessate, rispettivamente, da uno stato di alta e media severità idrica.
L’acqua svolge un ruolo cruciale per l’agricoltura. L’irrigazione rappresenta infatti la maggiore pressione sulla risorsa idrica, soprattutto nei territori in cui precipitazioni e umidità del suolo non sono sufficienti a garantire il fabbisogno idrico delle colture. Considerando che il comparto agroalimentare ha guidato la crescita delle esportazioni dei distretti meridionali nei primi nove mesi del 2023 (+6,9% su base annua) e pesa più del 60% dell’export totale dei distretti meridionali, è indubbio che la rilevanza economica della risorsa idrica sia di assoluto rilievo nelle regioni del Sud.
Tale conclusione si rafforza se ci focalizziamo sul settore energetico, legato a doppio filo alla disponibilità della risorsa idrica, sia nei comparti tradizionali come la produzione idroelettrica e termoelettrica, sia per quanto concerne lo sviluppo di alcune tecnologie a basse emissioni di carbonio cruciali per la transizione – si pensi agli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, particolarmente idroesigenti. Tra le sue Raccomandazioni all’Italia in merito al nuovo Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2021-2030 (PNIEC), la Commissione europea ha suggerito di “dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell’energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia”, indicando la necessità di un ulteriore sforzo in questo ambito. L’interdipendenza tra risorse idriche e settore energetico rende dunque necessario un approccio integrato per raggiungere al contempo gli obiettivi della sicurezza idrica e della transizione energetica.
La specializzazione produttiva e le esigenze legate alla transizione energetica indicano la rilevanza strategica della risorsa idrica per il Mezzogiorno, aumentando l’urgenza di interventi infrastrutturali tempestivi finalizzati alla riduzione delle perdite nella distribuzione, al potenziamento della capacità di invaso[1], alla manutenzione e all’ammodernamento delle reti, grazie anche alla digitalizzazione e a un più efficace sistema di monitoraggio.
L’Italia eredita storicamente una carenza di investimenti nel comparto idrico, che spiega la vetustà della rete e l’elevata quota di perdite. Utilitalia stima un significativo incremento degli investimenti lordi pro capite (+113%) negli ultimi anni, dai 33 euro del 2012 ai 70 euro per abitante del 2023. Tuttavia, questo miglioramento non ha consentito all’Italia di raggiungere gli standard europei: se guardiamo alla media quinquennale 2019-2023, l’Italia avrebbe raggiunto i 59 euro per abitante, un livello ancora distante dagli 82 euro per abitante della media europea, così come dagli oltre 90 euro di Francia e Germania.[2]
La capacità d’investimento è peraltro molto diversificata tra gestori industriali e le gestioni in economia: i primi hanno garantito nel 2022 una spesa d’investimento media di 64 euro per abitante, decisamente superiore rispetto alle gestioni in economia (11 euro per abitante). La maggior parte delle gestioni in economia interessa il Sud Italia dove sono 1.206 i Comuni che gestiscono il servizio idrico in proprio, pari a circa 7,7 milioni di persone su un totale di 8,2 milioni di individui con servizio a gestione comunale a livello nazionale.
Il divario in termini di capacità d’investimento si osserva anche a livello territoriale. I gestori industriali registrano un livello pro-capite di investimento particolarmente elevato nel Centro (75 euro l’anno per abitante) Nord-Est (56 euro) e Nord-Ovest (53 euro), mentre i valori più bassi si riscontrano nel Mezzogiorno (32 euro). Per le gestioni in economia, il dato scende ulteriormente al Sud (9 euro per abitante) e nelle Isole (7 euro per abitante).
La carenza di investimenti è in parte imputabile al livello delle tariffe[1] che in Italia è storicamente molto basso rispetto al resto d’Europa. Nel 2022, la tariffa media italiana era di 2,1 euro al metro cubo, inferiore alla media europea (3,2 €/m3) e molto al dì sotto di quella di Francia (4,1 €/m3), Germania (4,6 €/m3) e Danimarca (9,3 €/m3).[2] Una delle possibili soluzioni alla carenza infrastrutturale potrebbe dunque essere l’innalzamento del livello delle tariffe. Da questo punto di vista, il caso della Toscana è emblematico: la realizzazione di significativi investimenti sulla rete (327 milioni nel 2022, pari a circa 90 euro per abitante) è stato possibile grazie all’incremento delle tariffe, tra le più alte d’Italia (2,7 €/m3). Per il Sud, tuttavia, questa strada è decisamente più difficile da perseguire, almeno nel breve periodo, sia a causa del water service divide che si è venuto storicamente a determinare sia per le sfavorevoli condizioni macroeconomiche di contesto. La realizzazione degli investimenti indispensabili per ammodernare il sistema idrico integrato delle regioni meridionali necessita in ogni caso di risorse ingenti, che devono essere rintracciate anche in altre fonti.
La mobilitazione di risorse ulteriori attraverso le politiche pubbliche diventa allora cruciale, specialmente per il Mezzogiorno. Da questo punto di vista, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha certamente dato un impulso importante, destinando (inizialmente) 4,38 miliardi al comparto idrico (M2 C4) in particolare per nuovi invasi (2mld), perdite idriche (900 mln), sistema irriguo (880 mln), reti fognarie e sistemi di depurazione (600 mln). La rimodulazione del PNRR, dovuta anche ai rincari energetici e dei beni intermedi che hanno caratterizzato il triennio 2021-2023, ha comportato un incremento delle risorse di 1,024 miliardi[3] destinate alla riduzione delle perdite di rete, di cui il 40% indirizzate al Mezzogiorno (410 mln).[4] Dopo la revisione, il comparto può contare su una dotazione complessiva di 5,4 miliardi dal PNRR che si sommano ai 476 milioni del ReactEU nell’ambito del PON-IeR 2014-2020.[5] Sono da considerare anche le risorse del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) introdotto nel 2017 (L. 205/2017) e modificato nel 2021. Il Piano ha attualmente una dotazione finanziaria di 2 miliardi suddivisa sul periodo 2018-2033 ed è finalizzato alla programmazione degli interventi a favore dell’approvvigionamento idrico primario, tra cui la manutenzione straordinaria, la realizzazione di nuovi serbatoi e gli interventi sulle reti.
Il PNRR ha senza dubbio accelerato la dinamica degli investimenti, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e il fabbisogno del settore idrico rimane superiore rispetto alle risorse complessivamente mobilitate dal settore pubblico e privato. L’Allegato al DEF “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) fornisce infatti una ricognizione delle opere necessarie a garantire la sicurezza idrica dell’Italia, mettendo in evidenza che l’adattamento degli invasi e degli acquedotti al cambiamento climatico, il miglioramento della capacità di raccolta, la drastica riduzione delle perdite e il completamento delle infrastrutture incompiute richiedono risorse per circa 12 miliardi (molte delle quali nel Mezzogiorno), che diventano 13,3 miliardi se si includono anche gli interventi per la riduzione delle perdite nelle reti ad uso potabile (1,17 mld) e le coperture finanziarie delle opere finanziate (150 mln).
Il divario complessivo tra risorse stanziate e fabbisogno di investimenti del comparto idrico ammonta dunque a circa 5,4 miliardi di euro, una cifra significativa. Se una quota rilevante di questo gap potrà essere colmata attraverso l’innalzamento delle tariffe nelle aree più abbienti del Paese, nei prossimi anni le sorti delle infrastrutture idriche del Mezzogiorno dipenderanno soprattutto dall’utilizzo efficace delle risorse del PNRR e del PNIISSI. Con l’esaurirsi di queste, in ogni caso, sarà indispensabile aver avviato un processo di trasformazione del settore in grado di superare le gestioni in economia e favorire l’ingresso di gestori industriali dotati di competenze e dimensioni adeguate in termini di capacità di programmazione e realizzazione degli investimenti. In caso contrario, il gap infrastrutturale con il resto del Paese continuerà ad aumentare, a danno di tutte le filiere strategiche del Mezzogiorno e dei propri cittadini.
[1] Tra i sistemi che caratterizzano l’approvvigionamento idrico vi è la capacità d’invaso. In Italia vi sono 532 grandi invasi di capacità superiore a 1 milione di metri cubi d’acqua, per un volume complessivo di 13,8 miliardi di metri cubi d’acqua. Il 35% di questi (188 invasi) è localizzato nelle regioni del Sud per una capacità invasabile pari a circa 6,5 miliardi di metri cubi d’acqua, il 47% del totale nazionale. A differenza delle altre macroaree del Paese, dove il principale scopo degli invasi è la fornitura di energia elettrica, la maggior parte degli invasi al Sud viene impiegato per fini irrigui (il 50% del totale sulla macroarea), seguono la produzione di energia idroelettrica (il 27%) e la distribuzione di acqua potabile (13%).
[2] I dati sugli investimenti lordi pro capite relativi al 2022 e 2023 sono stime riprese dal Blue Book 2024 (Utilitalia). I dati relativi alla media UE e a Francia e Germania fanno riferimento alla media quinquennale al 2021.
[3] Negli anni più recenti, l’intervento regolatorio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha favorito gli investimenti, definendo il metodo tariffario a livello nazionale, che fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato in modo che la tariffa copra i costi per la realizzazione degli investimenti sulla rete di acquedotto e fognatura e i costi operativi del gestore. A livello locale, l’Ente di Governo d’ambito (EGA) definisce il piano di interventi che il gestore deve realizzare e determina le tariffe in conformità al metodo tariffario stabilito da ARERA.
[4] Dati Global Water Intelligence.
[5] Da segnalare che tali risorse “addizionali” del PNRR, così come quelle destinate ai territori colpiti da eventi alluvionali, scaturiscono dall’inserimento nel PNRR rimodulato di ulteriori “progetti in essere” per circa 2 miliardi di euro, che avevano già la loro copertura sul bilancio dello Stato.
[6] Da considerare inoltre le risorse (1,2 miliardi) destinate alle “Misure per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico” (M2C4, 2.1).
[7] Se estendiamo l’analisi alle proposte non finanziate includendo il cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti, le opere proposte dal comparto per le linee di intervento arrivano a quasi 7 miliardi di euro.