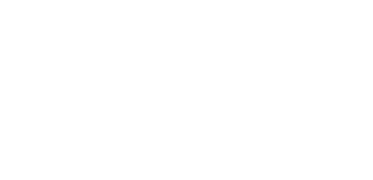Le politiche di mitigazione del cambiamento climatico e il ritorno della sicurezza energetica in cima all’agenda politica europea dopo lo scoppio della guerra in Ucraina hanno imposto un cambio di paradigma nel comparto energetico, investito da mutamenti profondi che si ripercuotono sull’intera struttura produttiva. La crescita della capacità rinnovabile installata nel 2023 è stata significativa a livello europeo (+73 GW) e italiano (+5,8 GW). Tuttavia, tali progressi nascondono la sotto-dotazione manifatturiera e la dipendenza strategica dalle importazioni asiatiche di pannelli e turbine, raddoppiate nel 2022 a 22 miliardi (+104%). Se è indispensabile accelerare ulteriormente la produzione di energia rinnovabile, aumentando più rapidamente la capacità installata, è allo stesso tempo essenziale sviluppare la capacità produttiva di tecnologie verdi.
Il Mezzogiorno ha le risorse e le potenzialità per assumere un ruolo centrale in questa partita europea, ma occorre superare l’idea del Sud come mero hub energetico, in contraddizione con il nuovo approccio alle politiche industriali e miope rispetto agli obiettivi di autonomia energetica e coesione territoriale. La politica industriale nazionale non dovrebbe dunque limitarsi alle infrastrutture di rete che collegano i territori più competitivi in termini di produzione rinnovabile ai centri industriali nazionali ed europei, ma puntare con forza allo sviluppo delle filiere legate alle tecnologie verdi nel Mezzogiorno. Proprio in questo settore si potrebbe dispiegare il potenziale del Sud, che può ambire a diventare un polo produttivo strategico rispetto agli obiettivi dell’autonomia strategica europea. Nella struttura economica meridionale, sbilanciata su attività di servizio a bassa produttività, emerge infatti un gruppo “di testa”: imprese che spiccano per performance economiche particolarmente soddisfacenti e sono posizionate in vari segmenti delle catene del valore strategiche, tra cui proprio quella energetica.
Le circa 90 mila imprese che soddisfano i requisiti della Smart Specialization Strategy (S3) sono diffuse in diversi settori nevralgici tra cui agroalimentare, chimica verde, automotive, aerospazio: riconoscere le specializzazioni produttive del Mezzogiorno già integrate nelle filiere strategiche europee costituisce una precondizione rispetto a una politica industriale in grado di coniugare obiettivi di sviluppo, sicurezza energetica e coesione territoriale; supportare queste filiere – così come quelle di frontiera – consentirebbe inoltre di sviluppare la rete produttiva locale e attirare investimenti esteri, con effetti di indotto positivi per l’intero tessuto industriale nazionale. Affinché le risorse messe in campo per i singoli progetti siano utilizzate in maniera efficace, è indispensabile una mappatura dei fabbisogni essenziali di ciascuna filiera e del rispettivo posizionamento internazionale, con un focus sulle dipendenze strategiche in una prospettiva europea. Così come risulta imprescindibile una programmazione pubblica di lungo corso che collochi lo sviluppo territoriale all’interno di una strategia continentale: il contributo del Mezzogiorno dovrà essere orientato al rafforzamento della filiera europea, altrimenti le economie di scala sviluppate dagli altri grandi attori internazionali impediranno l’emergere di un nuovo protagonismo industriale del Mezzogiorno.
Questo rilancio industriale necessita, infine, di un quadro di policy sistemico, organico e prospettico volto a sostenere e qualificare l’offerta produttiva del Mezzogiorno, anche mediante strumenti complementari e selettivi di politica industriale: ZES unica per il Mezzogiorno, Contratti di sviluppo, Accordi di Innovazione. La ZES Unica per il Mezzogiorno, in particolare, costituisce un tentativo di operazione di sistema che va in questa direzione, estendendo a tutto il Sud i vantaggi fiscali e di sburocratizzazione legati alle attuali ZES. La ZES Unica rappresenta una forma di fiscalità compensativa orizzontale per gli investimenti al Sud e presenta quindi indubbi vantaggi potenziali, ma rischia di produrre effetti limitati se non sarà pienamente integrata nelle politiche industriali regionali e nelle più ampie strategie di sviluppo del Paese. Saranno in particolare due aspetti a decretare il successo della ZES Unica: il primo riguarda la capacità della nuova governance di assicurare la semplificazione amministrativa alla base del disegno originario delle ZES, il secondo dipende dalla capacità di recuperarne la finalità di strumento di politica industriale e infrastrutturale.
Sul primo punto, sarà cruciale la capacità della Struttura di missione nazionale di svolgere la funzione di sportello unico delle autorizzazioni per l’intero territorio meridionale. Dato il numero elevato di progetti di investimento che si prevede potrà pervenire, ciò richiederà inevitabilmente un rapporto cooperativo con le Amministrazioni locali, senza disperdere il lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali ed evitando nella fase transitoria rallentamenti nel passaggio di consegne. L’introduzione di una governance nazionale guidata dalla Presidenza del Consiglio può tuttavia essere l’occasione per rafforzare il coordinamento degli interventi e favorire l’adozione di procedure più omogenee, superando i localismi e le frammentazioni che hanno caratterizzato le politiche di sviluppo degli ultimi decenni. Per quanto riguarda il secondo punto, il successo della ZES Unica dipenderà dai contenuti del Piano Strategico, che dovrà valorizzare le specificità produttive, economiche e sociali dei territori. Non meno importante sarà l’individuazione dei settori di frontiera nei quali favorire l’attrazione dei grandi investimenti necessari ad accrescere la competitività del sistema economico meridionale.