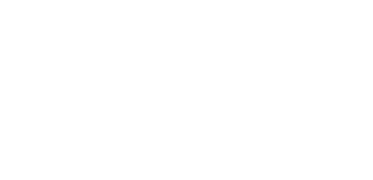Novembre 2025
Il PuntoSVIMEZ – novembre 2025
Il Mezzogiorno nella manovra di bilancio
Il DdL di Bilancio 2026 è orientato a una riduzione graduale del deficit, in coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nell’ambito del Piano Strutturale a Medio termine. L’obiettivo è l’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo entro il Consiglio di marzo 2026. Dopo anni di politiche espansive dettate dalla crisi pandemica, la manovra prosegue la svolta verso il consolidamento iniziata nel 2025. La legge di Bilancio 2026 chiude di fatto il ciclo di politica economica post-Covid caratterizzato da finanza pubblica espansiva e crescita degli investimenti. La manovra risulta di fatto neutrale sulla crescita economica, prevedendo modesti interventi finanziati con analoghi tagli di bilancio, concentrati sulla spesa per investimenti: PNRR e Fondo sviluppo e coesione. Una buona notizia per la stabilità finanziaria e per le prospettive di una uscita anticipata dell’Italia dalla procedura di disavanzo eccessivo, che suscita tuttavia qualche preoccupazione per le prospettive di crescita in particolare per il Mezzogiorno, che più delle altre aree del Paese aveva beneficiato di questo ciclo espansivo.
Dal lato delle coperture, il consolidamento viene perseguito attraverso una sensibile riduzione delle spese in conto capitale nel 2026 (-4,7 miliardi), in larga parte riconducibili alla rimodulazione del PNRR. Negli anni recenti, la spesa in conto capitale ha fortemente contribuito alla crescita del paese, in particolare del Mezzogiorno. La circostanza che questa riduzione sia riconducibile al PNRR rende ancora più importante le modalità con cui il Governo sta procedendo alla rimodulazione, in particolare per quel che concerne le modifiche tra vecchi interventi da definanziare e nuovi da inserire e le conseguenze di queste rimodulazioni sull’allocazione territoriale delle risorse. Si segnala, inoltre, che l’articolo 129, del DdL, al comma 6 dispone il versamento all’Entrata del bilancio di 1.100 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027 di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) iscritte in conto residui. A ciò si aggiunge il comma 15 dell’articolo 129, che dispone la riduzione complessiva di 300 milioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (100 milioni per ciascuna annualità 2026-2028), ciclo di programmazione 2021-2027. In totale le dotazioni FSC si riducono complessivamente di 2,4 miliardi.
Gli effetti negativi dei minori stanziamenti per le infrastrutture potrebbero essere attenuati dall’effettiva applicazione della “clausola” dell’articolo 11 del decreto coesione del 2024, che prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare alle regioni del Mezzogiorno il 40% delle risorse ordinarie in conto capitale. Per l’effettiva implementazione di questa clausola andrebbero resi disponibili i dati risultanti dai meccanismi di monitoraggio previsti dalla norma, nonché l’introduzione di sanzioni in caso di mancato rispetto, attualmente non previsti.
La spinta propulsiva della spesa in conto capitale sulla crescita del Mezzogiorno nei prossimi anni è legata a doppio filo all’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), per il quale la legge di bilancio prevede, per la prima volta, limiti annuali di spesa. Si tratta tuttavia di limiti elevati (7.134 milioni per il 2026, 8.684 milioni per il 2027, 8.954 milioni per il 2028) che, se effettivamente raggiunti, potrebbero dare continuità alla fase propulsiva degli investimenti nel Mezzogiorno. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2025 il FSC ha evidenziato una spesa inferiore ai 2,5 miliardi di euro. Assume pertanto particolare importanza un’azione del Governo volta ad accelerare l’avanzamento dei Piani sviluppo e coesione 2014-2020 e a verificare il rispetto dei cronoprogrammi di spesa previsti negli Accordi per la coesione 2021-2027 sottoscritti con le regioni. Allo stesso tempo, andrebbe completata la sottoscrizione degli accordi per la coesione con i vari Ministeri – solo la scorsa settimana sono stati firmati i primi accordi, per importi FSC pari a 2 miliardi.
L’articolo 95 estende al triennio 2026-2028 il credito d’imposta ZES Unica, con risorse pari a: 2,3 mld (2026), 1 mld (2027), 0,75 mld (2028). La SVIMEZ valuta positivamente l’estensione pluriennale, che riduce l’incertezza per le imprese e consente una pianificazione più stabile degli investimenti. Con la riforma della Zes Unica si sono manifestati segnali positivi in termini di efficienza dello strumento agevolativo. Rispetto alla precedente governance, si è registrato un dimezzamento dei tempi necessari per avviare gli investimenti. È necessario ora affiancare alle misure orizzontali dell’intervento, quali le agevolazioni fiscali e le semplificazioni burocratiche, una maggiore selettività che favorisca lo sviluppo di filiere realmente strategiche. L’aggiornamento del Piano strategico, in scadenza nel 2026, potrebbe essere l’occasione, anche alla luce dell’estensione a Marche e Umbria, per favorire il cambiamento strutturale, in grado di integrare il sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche europee.
La manovra compie passi limitati e al di fuori di un piano organico verso l’attuazione del federalismo fiscale regionale, milestone del PNRR da completare entro aprile 2026. In particolare, il DDL si occupa di LEP in materia di assistenza e istruzione (limitatamente all’istruzione universitaria), lasciando ancora indeterminati i LEP relativi all’istruzione professionale e al trasporto pubblico locale.
Riguardo all’assistenza, il DDL sistematizza in larga parte i LEPS già previsti dalla legislazione vigente, accorpandoli in un “Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale” con due novità: l’introduzione di un LEP relativo alla presenza di una équipe multidisciplinare in ogni ambito territoriale sociale (nella misura di uno psicologo ogni 30.000 abitanti e un educatore socio-pedagogico ogni 20.000), nonché quella di un LEP relativo ai servizi domiciliari socio-assistenziali per i soggetti non autosufficienti (nella misura di un’ora a settimana). Sono previsti nuovi stanziamenti solo per le équipe multidisciplinari (0,2 miliardi a decorrere dal 2027), mentre per il secondo dei nuovi LEP devono provvedere le amministrazioni regionali e locali con le risorse disponibili nei loro bilanci. Anche gli altri LEP già previsti dalla normativa sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente. La Commissione tecnica fabbisogni standard (CTFS) dovrà definire i criteri di riparto. Un ulteriore intervento – a cavallo fra assistenza e istruzione – è quello sulle attività di supporto all’autonomia e alla comunicazione personale degli studenti disabili. Il DDL definisce LEP il numero di ore indicato per tali attività nei Piani educativi individualizzati (PEI) formulati dalle scuole. Anche in questo caso la copertura finanziaria è data dalle risorse già disponibili a legislazione vigente; la CTFS dovrà definire i criteri di riparto. Infine, in materia di istruzione l’unica misura è il rifinanziamento per 0,25 miliardi l’anno a decorrere dal 2026 del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.
Per dare compiuta attuazione al federalismo regionale resta ancora molto da fare: occorre completare l’individuazione dei LEP nell’istruzione e nel trasporto pubblico locale, istituire il fondo perequativo regionale e procedere alla “fiscalizzazione dei trasferimenti statali”. L’esperienza recente dimostra che l’obiettivo di attenuare i divari territoriali nei livelli di servizio difficilmente può essere perseguito in assenza di stanziamenti idonei. I LEP indicati dalla manovra sarebbero invece largamente finanziati a parità di risorse e il richiamo alle disponibilità finanziarie dei bilanci locali sembra mettere in discussione il carattere di “essenzialità” delle prestazioni, poiché la loro erogazione sarebbe condizionata dalla capacità fiscale locale (contrariamente a quanto stabilito dalla legge 42 del 2009). Anche a parità di risorse, un’attenuazione dei divari territoriali potrebbe essere realizzata attraverso una revisione dei criteri di riparto delle risorse, chiaramente improntata a finalità perequative. Il DDL, tuttavia, prevede che nell’allocazione delle risorse si tenga conto “degli effettivi beneficiari dei servizi”, riproponendo in tal modo il criterio della spesa storica che perpetuerebbe le differenze attuali e i divari di cittadinanza.
Il Sud nel triennio 2021-24 è cresciuto più del Nord, e probabilmente continuerà anche nel 2025, ma prima di parlare di “Locomotiva del Paese” dovremmo considerare quanto di questa ripresa sia stato riconducibile al ciclo di politiche espansive 2021-2024: i bonus alle famiglie del primo biennio post-Covid, gli incentivi all’edilizia e poi gli investimenti del PNRR. Senza negare gli altri elementi positivi che hanno caratterizzato il sistema delle imprese e l’ottima performance di alcuni settori esportatori, a livello macroeconomico ciò che ha fatto la differenza è stata la crescita degli investimenti: prima quelli privati trainati dal super bonus edilizio, poi quelli pubblici grazie al PNRR. La dimostrazione che il Sud non è un vuoto a perdere, che, se si investe, reagisce agli stimoli e attiva percorsi virtuosi di crescita economica ed occupazionale. Se vediamo in particolare i dati della spesa dei Comuni del PNRR, si nota che anche le amministrazioni locali, se stimolate e sottoposte alla pressione del risultato, sono in grado di realizzare investimenti in tempi non dissimili dal resto del Paese.
Responsabilità della politica, nazionale e locale è ora quello di dare continuità agli investimenti, sia in infrastrutture economiche (ferrovie, reti digitali) sia in quelle sociali (asili nido, scuole, ospedali di comunità), decisivi per migliorare la capacità competitive delle imprese e per rendere omogenei i diritti di cittadinanza nelle diverse aree del Paese. Per fare questo, passata la fase delle “vacche grasse”, bisogna utilizzare al meglio le risorse disponibili. Innanzitutto, occorre vigilare sull’attuazione del PNRR, completare le parti più in ritardo, a partire dalla sanità territoriale, di competenza delle Regioni, che mostrano livelli di avanzamento al Sud particolarmente bassi. Bisogna poi accelerare sulla riforma della politica di coesione 2021-27, riprogrammando le risorse sulle priorità indicate dalla Commissione, a partire dagli investimenti sul sistema idrico e sull’edilizia sociale. Due temi su cui spesso l’assenza di una strategia territoriale ha compromesso la capacità di investire, anche valorizzando esperienze positive quali quelle del Comune di Napoli, che nella rigenerazione urbana ha conseguito importanti risultati. Infine, le risorse degli Accordi per la Coesione che, da soli, rendono disponibili circa 20 miliardi di euro per le regioni del Sud, da spendere nei prossimi 5 anni sulle priorità e gli interventi concordati con il Governo. Puglia e Campania hanno oltre 4 miliardi di interventi finanziati che potrebbero sostenere la dinamica degli investimenti e la crescita dell’occupazione. La sfida che hanno dunque davanti le amministrazioni locali, a partire dalle Regioni Campania e Puglia ora di fronte alla sfida elettorale, è utilizzare al meglio queste risorse, che rischiano, con i nuovi vincoli di bilancio, di essere le uniche disponibili. L’auspicio è che in questa complessa sfida elettorale, spesso schiacciata su personalismi e gossip, emerga chiaramente da parte di chi si candida a governare un progetto di medio termine che identifichi, come fatto con il PNRR, obiettivi e tempistiche definite. Servono dunque capacità realizzative e visione per evitare che la ripresa delle regioni del Sud e il suo effetto traino sull’economia nazionale rimanga un’eccezione di questi anni.